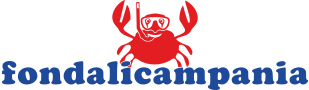Questa volta non parliamo del corallo in generale, o di quello che è possibile trovare nei fondali della Campania, ma di una storia che abbiamo rintracciato, molto triste in verità, ma che ci fa’ capire qualora l’avessimo dimenticato, come e quanto il mare è parte integrante delle nostre più belle tradizioni.
La vicenda risale alla metà del 1800. La nave corallina “S. Giuseppe” era una bella barca di 15 metri con vela aurica, bompresso e fiocco.
A quel tempo, evidentemente, non c’era tutta la tecnologia che si ha oggi, per la raccolta del corallo, autentico ed ennesimo tesoro che i fondali marini donano agli umani.
Per fare un esempio, ai giorni nostri bastano tre persone di equipaggio per far funzionare “l’ingegno”, il caratteristico sistema di pesca del corallo consistente nell’ancoraggio del fondale interessato , ma un tempo ne occorrevano almeno una ventina. E poiché si operava a vela, il rischio della vita nei casi di burrasca era piuttosto frequente.
Il comandante era tale Vincenzino Cuoco ed aveva fatto base a Sorrento, per l’inizio della stagione. Si battevano i banchi tra Punta Campanella e Capri. Il lavoro era duro e massacrante. Si andava tutto il giorno su e giù per lo stretto.
Una mano al timone e l’altra al lungo cavo di canapa che arava “l’ingegno”, giù nel buio fino ad una profondità di 150 metri. Si tenevano gli occhi fissi sulle vele che, in continuazione, si “allascavano” o si “tesavano”, a seconda del bacio del vento sulle labbra umide. Poi veniva il momento del dolore.
Il grande argano ingollava fatica e sudore degli uomini dell’equipaggio e si prospettava un inverno misero o ricco per la famiglia che aspettava laggiù a Torre del Greco.
E quando “l’ingegno” veniva a galla con i rami fiammeggianti del rosso corallo, lacrime di gioia venivano fuori da quei cuori semplici.
Quella volta uscirono in un giorno di forte libeccio. Vincenzino Cuoco, cautamente, aveva detto: “Facimmo ‘na calata sola.” Il S. Giuseppe mise la prua verso il Capo.
Il mare livido lo investiva di traverso quasi a volerlo rimandare indietro, verso l’ancoraggio sicuro. Poi, “l’ingegno” venne calato.
Il lungo cavo di canapa scivolò giù nel buio delle profondità ed il forte vento fece correre “l’ingegno” impazzito lungo tutto il banco. Quindi, come colpito da una mazzata, l’imbarcazione si arrestò di colpo, facendo vibrare vistosamente l’albero.
Vincenzino Cuoco fece mollare le vele e gli uomini corsero all’argano. Nel frattempo, il cielo era diventato “niro ‘e pece” e i contadini che nei giardini carichi di uva e di agrumi, lassù in alto sulla montagna vivevano la loro solita giornata di lavoro, smisero “e faticà”, per fissare nelle loro menti quei minuti di lotta. Così, visto dall’alto, il S. Giuseppe non era altro che una piccola e trascurabile cosa posta sulla rabbia del mare.
Vincenzino Cuoco, per infondere coraggio a fronteggiare le onde sempre più alte e minacciose, gridò: “Piccirì, ca avimmo truvato ‘a furtuna!” Le sue mani, molto esperte, avevano sentito le retazze ghermire tanto, ma tanto corallo giù nel buio di una gola profonda. Avevano sfidato gli elementi, però c’era stata la ricompensa e adesso si trattava di portare a galla quel tesoro. La barca manovrò in tutte le direzioni, per fare uscire “l’ingegno” dalla stretta della roccia: alarono e poi tirarono.
Le mani “ro cumandante” e quelle dei suoi compagni divennero bianche a forza di stringere il cavo, nel tentativo di liberarlo, perché l’acqua verde e livida li sommergeva per intero. Da lassù, sulla montagna, i contadini non avevano mangiato un boccone e, appoggiati alle loro zappe, osservavano impietriti cosa avveniva di sotto.
Il sole era andato a morire da qualche parte lontana, molto al di là e al di sopra delle nuvole grigie, mentre il S. Giuseppe continuava la sua terribile lotta. Infine, fu il buio.
Davide De Stefano è attivista presso l’associazione Fondalicampania Aps, occupa il ruolo di Presidente. Fondalicampania fu fondata nel 2014 e si occupa di promozione e tutela dell’ambiente marino e costiero.